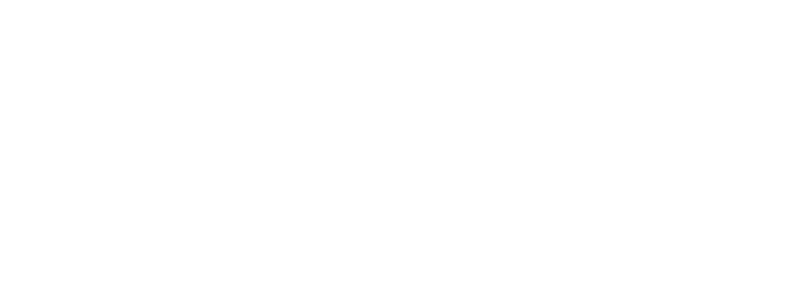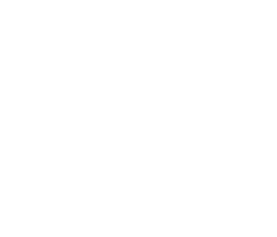Lo Stato di diritto e il diritto di punire
Che in Cina sia stata eseguita una condanna capitale non è una notizia, data la frequenza con cui in quel Paese ciò avviene. Si tratta dunque di “normalità”. A colpire è piuttosto il commento di un giornale di Pechino. Il giustiziato è un giovane contadino che aveva ucciso un funzionario del partito comunista. Costui aveva ordinato l’abbattimento della casa del giovane, che la stava ristrutturando nell’imminenza delle nozze ed era stato perciò fortemente sconvolto.
Sul caso si era mobilitata l’opinione pubblica con la richiesta della salvezza dello sventurato mediante la conversione della condanna a morte in ergastolo. Ma in Cina la giustizia, come si dice, non guarda in faccia a nessuno e fa il suo corso fino in fondo! Il giornale di Pechino ha scritto: “È il trionfo dello Stato di diritto, perché la legge si attiene solo ai fatti e non ammette compromessi con i sentimenti della gente”.
Dunque, come nell’antico rigore romano, la legge è dura, ma è la legge. Si prescinda ora dal rilevare che in ogni moderna civiltà giuridica la valutazione di un delitto pur gravissimo come l’omicidio e l’irrogazione della pena tengono conto della particolare situazione in cui l’atto criminale si è compiuto, e pertanto nella sentenza sono eventualmente riconosciute le attenuanti (o addirittura le esimenti come nel caso classico della legittima difesa).
Ciò che comunque nelle parole del giornale cinese inquieta è l’identificazione dello Stato di diritto con l’inflessibilità, anzi direi la spietatezza, della funzione punitiva, “senza compromessi con il sentimento della gente”. Se questa logica fosse dominante anche presso di noi, come senza contraddirsi potrebbe il partito radicale, nello spirito di Marco Pannella, perseguire il pieno compimento dello Stato di diritto e al tempo stesso battersi per promuovere una riforma umanizzante delle pene, non tanto per una generica aspirazione al diritto mite quanto piuttosto per soddisfare una ragionata esigenza di punizione personalizzata?
Si ometta pure l’ovvia osservazione che regole dettate dal legislatore legittimo in nome del diritto mite e della punizione personalizzata sarebbero anch’esse leggi dello Stato e dunque, se ciò avvenisse, il “sentimento della gente” non si troverebbe in intollerabile contrasto con la formale inesorabilità della legge, ma costituirebbe un materiale prezioso per suggerirle nuove linee. La questione va ridotta in termini elementari, a partire dal fatto che la maturazione civile appare frenata da vecchi modelli di stratificati pregiudizi.
In breve, se nella coscienza comune lo Stato di diritto viene dai più immaginato ancora secondo il modello dell’astratta durezza punitiva, e se l’attenzione alle concrete situazioni delle persone e ai loro condizionamenti sociali si considera un mero umanitarismo peloso, allora ogni tentativo di umanizzazione della pena evidentemente appare come una minacciosa lesione del principio stesso dello Stato di diritto. In verità il chiarimento decisivo, seriamente argomentato, è a portata di mano. Esso si trova bell’e pronto in un libro del 1764 ovvero, come tutti sanno, nel trattatello Dei delitti e delle pene, scritto da un giovane illuminista lombardo di nome Cesare Beccaria. Nel capitolo XXVII si legge: “Uno dei più gran freni dei delitti non è la pesantezza delle pene, ma l’infallibilità di esse”.
Perciò “la severità di un giudice inesorabile”, per essere utile “dev’essere accompagnata da una dolce legislazione”. In ogni caso “la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, ma unito con la speranza della impunità”. Peraltro la pena prevista dalla legge non solo dev’essere moderata, mai più grave di quanto strettamente lo esiga la riparazione del danno sociale, ma soprattutto, come s’insiste nel capitolo XIX, dev’essere sentenziata con prontezza, evitandosi quanto più è possibile la carcerazione preventiva.
Insomma non è la terribilità della pena a far desistere dal delitto. La pena prevista dalla legge sia dunque mite ma sia irrogata con prontezza, e sia certa la sua esecuzione! In questo quadro, lo Stato di diritto, i cui statuti garantiscono il rigoroso rispetto delle regole, e in particolare lo Stato non solo liberale nelle garanzie ma pure democratico perché legittimato dalla volontà popolare, non necessariamente, per non contraddirsi, si scontrerebbero con “i sentimenti della gente” calpestandone la normale pietà.
Il rigore della legge è intollerabile quando la legge è feroce, e lo è non solo per la sua eventuale crudeltà, ma per il fatto che in genere bersaglio sono i mal cresciuti, gli sbandati, gl’impoveriti, i profughi, insomma quelli che oggi con malcelato disprezzo vengono considerati gli “scarti”. Una giustizia giusta, in cui si esprima il senso profondo dello Stato di diritto, è certamente tale quando non guarda in faccia a nessuno, nel senso che non è rigida con gli umili e flessibile con i potenti.
Essa però è giusta compiutamente, solo quando dispone di regole capaci di personalizzare la pena, cioè di renderla adeguata alla realtà del reo, alla sua storia, al bisogno di “cura” che la sua esistenza ha per potere rientrare nella vita della società. Senza questa sistematica capacità la giustizia non riattiva la vita del reo, ma irreversibilmente la mortifica. Essa allora si riduce ad agire come il mitico brigante Procuste, il quale a coloro che gli capitavano sotto mano imponeva di stendersi su di un letto, e quelli troppo bassi li torturava per allungarne gli arti, gli altri troppo alti per accorciarli.
Oggi nella cultura europea, sotto le spinte convergenti di un più maturo umanitarismo razionale e di un nuovo umanitarismo religioso, pur tra molte incomprensioni e resistenze ideologiche, avanza timidamente la coscienza di un rapporto tra società e individui, rovesciato rispetto all’inveterata idea penalistica. Si comincia, sia pure ancora in pochi, a pensare che l’individuo, il quale viola la legge, sia in debito con la società. Di una persona che, condannata, ha scontato la sua pena, si usa infatti dire che “ha pagato il suo debito”.
Alcuni cominciano invece a pensare che sia la società in debito con l’individuo. Se il crimine è una patologia della società, ogni violazione della legge è un sintomo di questa patologia. Del resto, chi mai direbbe che un malato perché malato è in debito con il medico o con il servizio sanitario, e non invece che il medico e il servizio sanitario sono in debito di cura verso l’ammalato? Così, se si considerano le cose con limpida ragione, chi nel gioco delle forze reali risulta più forte è la società col peso schiacciante dei suoi colpevoli difetti, mentre enormemente più debole è l’individuo.
A dividere dunque equamente le responsabilità di un delitto, in prima fila sul banco degl’imputati dovrebbe sedere la società, con le proprie difettose istituzioni e strutture, e nell’ultima fila come complice minore l’individuo. Uno Stato che sia di diritto, il diritto di punire deve meritarselo, facendo della punizione non un facile scarico delle sue responsabilità, un vile lavarsene le mani, ma l’occasione di un impegno di attenzione straordinaria ad personam per restituire il reo alla dignità di socius della comune impresa civile.
Aldo Masullo – Il Mattino
Fonte: Oua.it