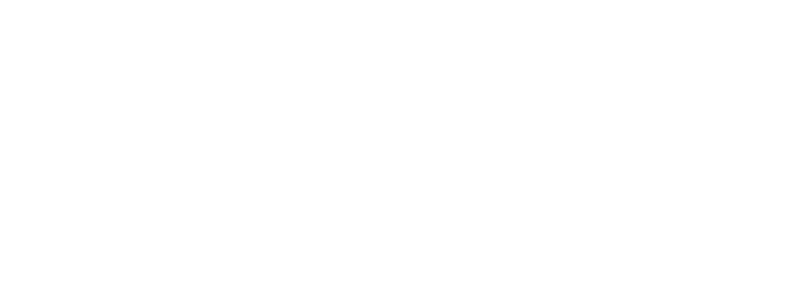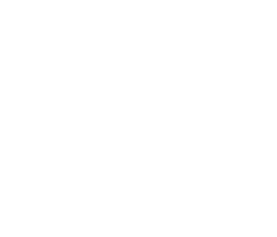Il digiuno dei reclusi, un ritorno alla società
Tra tante stragi del mondo, scatenate dall’umana follia, in Italia la devastazione di persone e di luoghi storici irrompe, scatenata dalla cieca strapotenza della natura. Intanto la faziosità referendaria divora le nostre energie politiche. Così, nel dibattito pubblico rimane inavvertita una significativa novità che rompe la nostra inerzia sociale di fondo.
Alla giornata conclusiva del “giubileo della misericordia” proclamato da papa Francesco, e alla concomitante “marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà”, indetta dal partito radicale, l’informazione diffusa è troppo disattenta. Eppure qualcosa di nuovo avviene. All’iniziativa aderiscono insieme uomini di fede religiosa e laicissime forze politiche. A suo sostegno vari esponenti radicali stanno attuando la pratica “non violenta” del digiuno, conforme al gandhiano insegnamento di Marco Pannella. Ora a questa pratica vanno motivatamente associandosi migliaia di detenuti.
Dico “motivatamente” non nell’ovvio senso del loro personale interesse agli auspicati provvedimenti di clemenza, bensì nel sorprendente senso della loro adesione ad una ragione civile di fondo, nella convinzione maturata in loro, come molte loro lettere attestano, dell’influenza del sistema penale sulla vita dell’intera società nazionale.
L’assidua, appassionata attenzione prestata dai radicali allo stato del sistema carcerario ha innescato un processo di maturazione attiva di forze civili sensibili e seriamente progressiste. Ma soprattutto ha suscitato un salto culturale in una parte sempre più larga della popolazione reclusa. Il fatto straordinario è che sempre più numerosi individui, quasi ostaggi della pur legittima pretesa punitiva pubblica, esclusi da ogni funzione sociale, espulsi dall’essere attivi, di fatto spogliati della dignità propria dei liberi, per la prima volta hanno lasciato alle spalle l’umiliazione della propria condizione e lo scoraggiato abbandono alla passività e al senso di mortificante impotenza.
Per la prima volta i reclusi assumono un protagonismo civile. Essi hanno cominciato a ragionare su errori compiuti e ingiustizie subite, a non chiedere pietà né ruminare rivalse, ma a prendere coscienza dei loro diritti di uomini, a riappropriarsi della dignità di cittadini. È come se l’arto a lungo addormentato di un corpo vivente si fosse ridestato e avesse ripreso a funzionare integrato nell’unitaria volontà, e così un grave peso di sociale inerzia finalmente si fosse sciolto nel flusso del collettivo fervore. Tutto ciò deve richiamare l’attenzione delle forze politiche, e dell’opinione pubblica che nel bene e nel male ne condiziona gli orientamenti, sul dettato dell’art. 27 della Costituzione.
Qui non solo si stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”, ma pure che esse “devono tendere alla rieducazione del condannato”. Certamente il lessico della norma non può più soddisfare. Fuori tempo è l’implicita referenza ideologica. Innanzitutto con l’espressione “senso di umanità”, la legalità della pena nella sua concreta somministrazione è fatta dipendere da un sentimento, cioè da un fattore soggettivo, troppo indeterminato, e la si espone così all’arbitrarietà. È questa la cultura collettiva e politica in cui finora è prosperata l’inciviltà del sistema carcerario italiano, dove accanto a poche eccezioni positive convivono situazioni vergognose. Ma l’inadeguatezza meno drammatica eppure più rilevante sta nel termine “rieducazione”.
Vi s’intravede, inconsapevole, una sfumatura di schizzinosità perbenistica, la convinzione che il condannato sia un “mal educato”, un individuo rimasto fuori dalla “buona educazione” in cui si riconosce la società normale. Da un tal punto di vista, ci si propone di sostituire nel reo la mala con la buona educazione, in breve di “ri-educarlo”. Ebbene, il digiuno, a cui molte migliaia di detenuti hanno deciso di partecipare, si badi bene, non per “protesta” ma in “sostegno” morale delle ragioni del giubileo e della marcia, non vuol essere un esibito avvio di “buona educazione”, quasi un passo verso la “ri-educazione”, e perciò un prepararsi a meritare una graziosa benevolenza. Si tratta di ben altro.
Qui è intervenuto il gesto, con cui un infelice popolo di esclusi dichiara il suo rientro nella comune appartenenza attiva, l’orgoglio dell’iniziata “reintegrazione” nella civile libertà. Si è oggi ad un punto in cui la ratio legis della seconda metà del secondo comma dell’art. 27, cioè l’intenzione normativa in essa implicita, non si può esprimere con il termine “ri-educazione”.
Essa piuttosto con nuova sensibilità va letta come “re-integro”. La pena infatti vale solo se l’esperienza, che l’individuo ne fa, lo sollecita a “ri-collocarsi”, a ri-occupare il posto perduto nell’organismo sociale. Funzione seria della pena, come oggi si comincia a intendere, non è la pretenziosa e mortificante “ri-educazione” del reo, bensì la rispettosa “re-integrazione” di cui egli è non il passivo gratificato ma l’impegnato attore. Tutto ciò significa che la pena detentiva, la cui funzione afflittiva sta nell’ assenza della libertà di scegliere dove e con chi stare, nell’essere insomma istituzionalmente in balia di altri, non può acuirsi fino a soffocare nel condannato l’attitudine più propriamente umana, l’agire produttivo, il riversare il pieno dell’ energia nel progettare ed eseguire un’opera.
Perfino il “lavoro forzato”, che un tempo si praticava nelle galere o negli ergastoli, per quanto umiliante e durissimo, è infondo meno brutale della costrizione all’inattività. Il lavoro forzato massacra i corpi, la forzata inattività massacra gli animi. L’esito infatti a volte è il suicidio. In gran parte delle nostre carceri le ore cadono lente nella testa dei detenuti e vi scavano buchi oscuri, come lo stillicidio li scava nella pietra. La riforma carceraria è un momento decisivo della ripresa del processo di modernizzazione dello Stato italiano. Si tratta di trasformazioni all’altezza della maturazione sociale in corso e al tempo stesso sue necessarie condizioni. Nelle carceri deve avvenire un cambiamento capace di rendere finalmente la detenzione uno stato di punizione, se meritata, non di tortura.
Al centro del cambiamento va posto il concreto rispetto del diritto insopprimibile alla vita attiva, a quella libera operosità che vale, essa prima d’ogni altra, a restituire al detenuto il rispetto di se stesso e a consentirgli così di re-integrarsi nella pienezza della sua appartenenza sociale. Rimane l’altra fondamentale condizione necessaria del rispetto di sé e della re-integrazione: la ragionevole speranza che in ogni caso l’esclusione un giorno possa aver fine. Ma questo è un altro, assai inquietante discorso.
Aldo Masullo – Il Mattino
Fonte: Ristretti Orizzonti